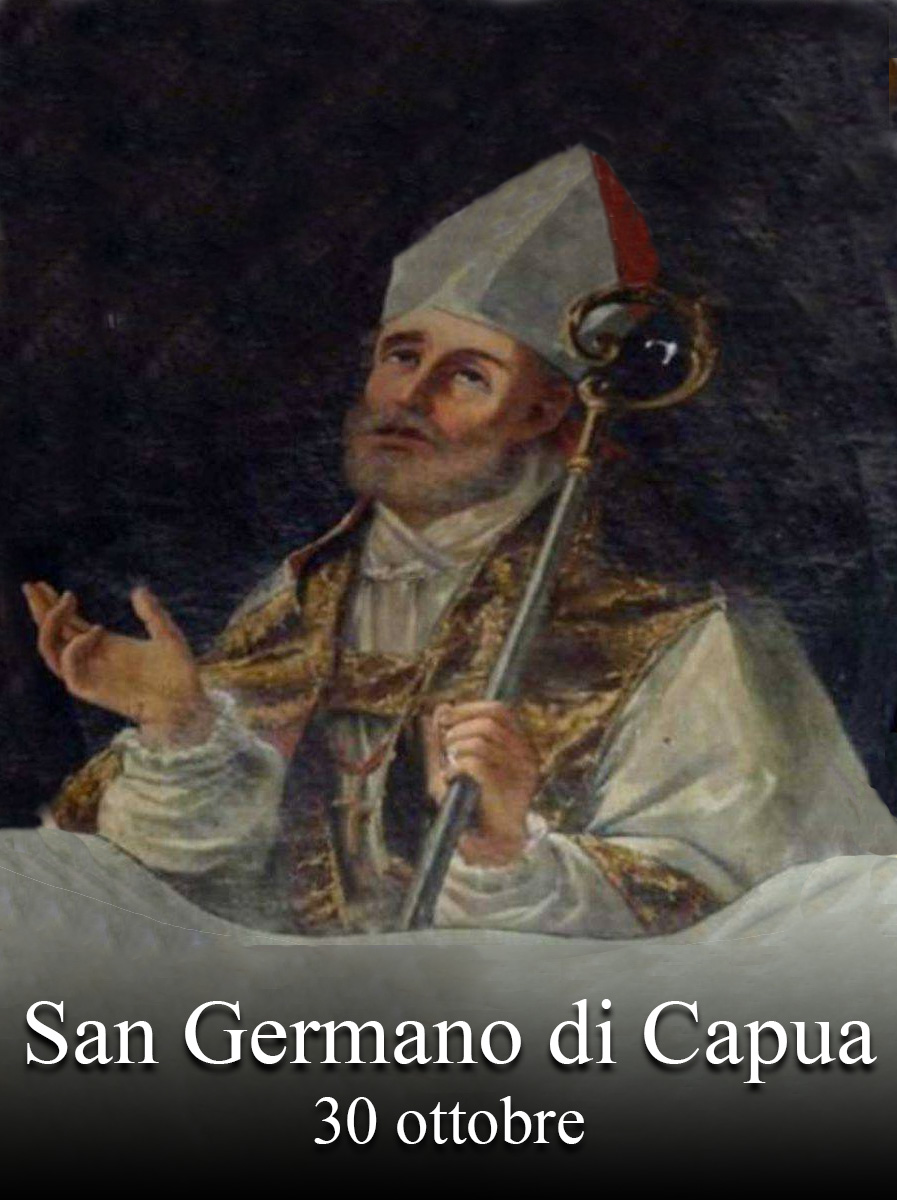
San Germano di Capua
Vescovo
Capua, V secolo - † 30 ottobre 541
Di san Germano esiste una vasta bibliografia che parla di lui, ma soprattutto della sua opera di vescovo. Nel mentre una ‘Vita’ anteriore all’873-74, scritta quindi più di tre secoli dopo la sua esistenza, dà del santo poche notizie generali. Egli nacque a Capua nel V secolo, figlio di Amanzio e Giuliana, illustri cittadini della storica città; alla morte del padre, Germano ereditò l’ingente patrimonio e con il consenso della madre vendette tutto e diede il ricavato ai poveri. Così poté dedicarsi più liberamente alla vita spirituale, a cui si sentiva chiamato, con sante letture, preghiere, ortificazioni. Nel 519 ca. essendo morto il vescovo di Capua Alessandro, fu designato a succedergli secondo le modalità dell’epoca, cioè eletto dal clero e dal popolo; dopo aver resistito per umiltà, alla fine accettò la carica. Il “Liber Pontificalis” aggiunge altre notizie sicure; il papa s. Ormisda (514-523) dopo che erano falliti i tentativi dei suoi predecessori e con l’infelice risultato di due sue legazioni, pensò di riuscire a portare a termine lo scisma acaciano in Oriente, quando divenne imperatore Giustino I nel 518. Lo scisma ebbe origine dal nome del patriarca di Costantinopoli Acacio († 489), il quale per porre termine alle controversie tra cattolici e monofisiti, accordatosi con quest’ultimi, suggerì all’imperatore Zenone di Bisanzio di promulgare nel 482, l’“Enòtico”, formula di unione dei due pensieri religiosi; la formula diretta a tutto l’impero non risolvendo alcuni punti teologici delicati, alla fine non soddisfece nessuno. Il papa Felice III depose e scomunicò Acacio nel 484, iniziando così lo scisma cosiddetto ‘acaciano’, durato 35 anni Lo scisma che dal 484 aveva separato da Roma la Chiesa d’Oriente, provocò anche il concetto di indipendenza dal Sommo Pontefice, il quale rivendicava il diritto pontificio a definire in materia di fede e di disciplina. L’imperatore Giustino I, già dai primi giorni dalla sua elezione, insieme ad altri personaggi influenti della sua corte bizantina, come il nipote Giustiniano e il patriarca Giovanni, chiesero al papa di inviare una legazione a ristabilire la pace fra le due Chiese. E così nel gennaio del 519 papa Ormisda d’accordo con Teodorico, che regnava in Italia con sede in Ravenna, inviò la sua terza legazione guidata dal vescovo di Capua Germano, e composta inoltre da un altro vescovo di nome Giovanni, dal diacono romano Felice, dal celebre Dioscoro, diacono alessandrino ma residente a Roma, dal prete romano Blando e dal notaio ecclesiastico Pietro. La guida di questa importante missione, rivela la stima che si aveva nella dottrina, saggezza e virtù di Germano. Essi furono accolti trionfalmente a Costantinopoli e ricevuti in solenne udienza dall’imperatore; letto il celebre ‘libellus’ di papa s. Ormisda, dopo breve contraddittorio condotto sapientemente dai delegati, alla fine i vescovi presenti convennero con le tesi pontificie e così il giovedì santo del 519, anche il patriarca Giovanni accettò la formula del papa. La pace nella Chiesa era stata raggiunta e lo scisma rientrato, fra l’esultanza generale e recandosi tutti in chiesa per il canto del ringraziamento a Dio. I Legati pontifici rimasero a Bisanzio più di un anno, per consolidare il risultato della conciliazione, anche nelle altre Chiese Orientali e per superare ulteriori contrasti dovuti ad irrequieti monaci sciti. Verso il 10 luglio del 520 essi ripresero la via del ritorno. S. Gregorio Magno nei suoi ‘Dialoghi’ racconta due episodi che riguardano s. Germano, il primo è che l’anima del diacono romano Pascasio, sarebbe apparsa a Germano nelle Terme di Agnano (NA) e che per le sue preghiere, sarebbe stata liberata dalle pene del Purgatorio. Il secondo episodio invece racconta, che s. Benedetto, mentre era in contemplazione a Montecassino, ebbe la visione dell’anima di s. Germano che saliva al cielo, trasportata dagli angeli e in un globo di fuoco; il santo patriarca allietato da tanta gloria del vicino vescovo di Capua, mandò persone fidate a chiedere di lui, ricevendo la notizia che nel momento stesso della visione, Germano moriva; era il 30 ottobre del 541. Germano fu sicuramente amico di s. Benedetto, come lo fu di s. Sabino vescovo di Canosa e del papa s. Giovanni I. Inizialmente Germano fu sepolto in Capua Vetere, nella chiesa di S. Stefano, dove lui stesso aveva fatto collocare le reliquie del santo protomartire e in questa chiesa, edificata dall’imperatore Costantino, s. Germano fu a lungo venerato. Poi costruita la nuova città, il suo corpo fu trasferito in essa. Nell’866 l’imperatore Ludovico II venne in Italia e dimorò per circa un anno a Capua e quando ripartì, portò con sé il corpo di s. Germano; poi passando per la città fondata dall’abate Bertario ai piedi di Montecassino, con il nome di Eulogimenopoli, egli vi lasciò parte delle reliquie di s. Germano; per la presenza di queste reliquie e per la venerazione che si era instaurata, la città si chiamò poi S. Germano, nome rimasto fino al 1863, quando fu mutato in quello più antico di Cassino. Nel suo viaggio di ritorno in Germania, Ludovico II lasciò altre reliquie del santo vescovo a Piacenza, dove da secoli sono venerate nella cripta della celebre chiesa di S. Sisto. E proprio da Piacenza nel 1846, l’abate di Montecassino Frisari, ottenne per la città di Cassino alcune reliquie di s. Germano, perché il dito del santo, che era l’unica reliquia superstite nel tempo, era andata persa durante i saccheggi dei francesi alla fine del secolo XVIII. Il culto per s. Germano, vescovo di Capua, è bene specificarlo, perché di santi o martiri con questo nome ve ne sono una trentina, senza contare i personaggi moderni; pur essendo presente in altre zone anche fuori d’Italia, è soprattutto attestato nelle zone di Capua e Cassino e di qualche parrocchia è pure il santo titolare. La sua festa è celebrata con particolare onore nell’Abbazia di Montecassino e soprattutto a Cassino dove è ancora speciale patrono.
Purtroppo tante opere d’arte che lo raffiguravano nella chiesa di Cassino, sono andate distrutte insieme alle reliquie, durante il disastroso bombardamento del 1944.
Autore: Antonio Borrelli

